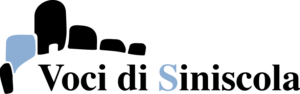Nei versi del celebre componimento “Procurade ‘e moderare” scritto alla fine del 1700 dall’intellettuale patriottico Francesco Ignazio Mannu, inno ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna dal 28.04.2018, doveva esserci anche un po’ di Baronia per i sentimenti di ribellione all’oppressione che accomunava tutti i sardi di valore. E in effetti di feudi e di baroni noi ne dovremmo sapere più degli altri territori isolani, almeno per il nome distintivo che ricalca la storia e disegna i confini.
Siamo nel periodo tra il 1323 e il 1326, quando dalla periferia meridionale del precedente Giudicato di Gallura, in piena conquista aragonese, nascono le Baronie di Posada e di Galtellì-Orosei, a chiudere definitivamente il proprio contributo alla storia giudicale e scavando le fondamenta della nostra preservata identità. Quella di un territorio resistente alle ingiustizie e alle conquiste, predati di beni e di tesori ma non di coraggio e umanità, intimamente riservati, in posizione di difesa, benché combattenti di prima linea nel processo di trasformazione dell’economia costiera e nel confronto con il mondo intero. C’è chi marca la propria residenza baroniese per mostrare con umorismo il carattere che certe circostanze richiedono, a me personalmente è capitato.

Terra di Baronia, storia e leggende misteriose, torri circolari a guardiania e un’antica Diocesi vescovile, risalente al XII secolo con la preziosa eredità di monumenti per il culto e di riti religiosi diffusi in tutta l’area, a testimoniare una massiccia e ancestrale devozione. Che la connessione con la spiritualità sia presente fin dall’antichità ce lo dicono gli studi e gli esperti ma con le nuove tecnologie, smartphone alla mano, anche la condivisione del patrimonio nuragico e prenuragico diventa realtà, accessibile a chiunque voglia esplorare il passato più remoto della zona. Io ho scelto una delle tante applicazioni disponibili, scoprendo una mappatura precisa di decine di siti archeologici nelle vicinanze, di cui non ne conoscevo l’esistenza. Ad esempio, non sapevo che nei pressi del vecchio faro a Capo Comino, a 120 mt sul mare, scrutava l’orizzonte il nuraghe complesso di Artora, sepolto da una piattaforma in cemento durante l’ultimo conflitto bellico. Chissà che prima o poi, non si possa restituire alla luce ciò che ne rimane.
Ad impreziosire tanta consistenza storica, ci pensano i colori e i suoni del folclore e della musica, le inquietanti maschere carnevalesche. L’arte medioevale, la poesia e la letteratura che conta, come quella delle canne al vento della Nobel nuorese Grazia Deledda che proprio dalla bassa Baronia prendeva spunto.
Numerose le storie della popolazione, semplici, di fatica, a volte drammatiche. Mi coinvolge il racconto di Francesco Corridore che scrive della lunga notte di Ognissanti, nel 1514, quando il villaggio di Siniscola viene sorpreso dai Mori e saccheggiato dopo crudeli torture e uccisioni. È di grande impatto l’immagine della gente pronta a lasciare le proprie case e a scappare nella fortezza posadina, per paura di nuove aggressioni. Un documento prezioso, di sopravvivenza, solidarietà e vicinanza.
Attraverso una sezione di circa 40 chilometri di Orientale sarda e penetrando nelle zone più interne, si coglie l’essenza di una subregione ancorata a quel passato più di quanto possa apparire, così evidente nella sobrietà della gente e nel legame ancora forte con la terra. Ma se la resistenza ai cambiamenti è tangibile e persino fiera soprattutto nelle usanze e nelle tradizioni, altrettanto lo è l’inserimento di una modernità travolgente e inevitabile. Una linea sottile divide l’ambizione di un progresso migliorativo dalla necessità istintiva a volte incompresa di salvare le proprie radici.
La filiera del turismo ha provato a interpretare questa ambivalenza identitaria con forme di accoglienza rurale, senza però riuscire a esprimere una rete di imprese efficace e interattiva ma rimanendo lontani da una organizzazione sistemica capace di creare ricchezza e abilità diffuse. Al netto delle singole esperienze di lustro, ciò che si vede in Baronia è la disaggregazione di interessi e del modus operandi, mancando il dialogo per compensare le carenze e potenziare i pregi. L’economia agropastorale e in genere tutti i settori economici sono colpiti dalla medesima disomogeneità e le unioni amministrative che potevano creare flussi positivi tra l’interno e la costa, e tra i vari paesi della Baronia, lasciano sulla carta un potenziale inespresso di progetti ambiziosi e tante risorse, solo parzialmente sfruttate.

Ecco perché parlare di Baronia non è semplice quando si abbandona il campo della mera accezione geografica. Che si debba guardare al passato per coltivare il senso di appartenenza lo posso comprendere, viste le vicende storiche in comune, ma è indagando qua e là, nella cerchia a me vicina che il sentimento baroniese si fa quasi inesistente, manco stessimo parlando di quello europeo. E rimango di stucco quando qualcuno ricorda le campagne elettorali di un tempo, quelle corpose dei partiti politici impegnati sul campo a coordinare migrazioni di manovalanza da un paese all’altro, in cerca di nuovi consensi. Allora sorrido perché tutto mi aspettavo fuorché una visione aggregante della politica, notoriamente divisoria o addirittura completamente ignorata.
Se il sistema Baronia stenta a partire, supposto sia mai stato improntato, altri sistemi locali sono in atto con tutto il loro splendore. Sono quelli naturalistici della Riserva della Biosfera “Tepilora, Rio Posada e Montalbo” riconosciuto dall’UNESCO nel 2017, del SIC Capo Comino-Berchida, delle oasi protette di Biderosa e Su Barone, dei molteplici percorsi montani e fluviali che tutti insieme fanno di quest’area della Sardegna una delle più significative dal punto di vista ambientale e dell’equilibrio e difesa della biodiversità. In attesa di arrivare preparati a una univoca qualità di servizi e di benessere, per fortuna, mi vien da concludere, ci sono loro.
Genni Piras.