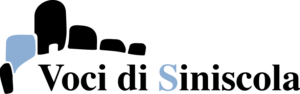Oggi voglio farmi questa domanda, per certi versi scomoda, perché richiede di razionalizzare sull’utilità di un patrimonio culturale la cui definizione risiede nell’intimo di ognuno.
A ciò si aggiunga un cortocircuito di interpretazioni che in alcuni casi porta a considerare il patrimonio culturale come qualcosa di immutabile, talaltra di tangente la nostra vita, talaltra dovuto e per certi versi scontato, e che non mi aiuta a focalizzarmi sulla risposta.
Mi dico “il patrimonio culturale è il patrimonio culturale”, in un estremo tentativo di togliermi dall’imbarazzo della evidente necessità di fare un passo indietro alla ricerca di una definizione di patrimonio culturale ancor prima di rispondere alla domanda iniziale.
Allora scrivo su ChatGPT: “cos’è il patrimonio culturale e a cosa serve?” e lei mi risponde: “il patrimonio culturale è l’insieme di tutte le testimonianze tangibili e intangibili che raccontano la storia di una comunità o di una nazione” e “svolge un ruolo attivo nel plasmare il presente e il futuro delle società contribuendo a costruire legami sociali, economici e culturali duraturi”
Ma il disagio aumenta, ne riconosco la ragionevolezza ma cosa significa?
Provo a indagare la natura multipla del patrimonio culturale, forte dell’assunto che tutte le parti che lo compongono siano riconducibili allo stesso campo semantico;
Leggo dunque la definizione di patrimonio paesaggistico sancita nella convenzione Europea per il paesaggio nel 2006, confidando che la sua specificità mi porti più vicina alla matrice comune:
il Paesaggio “designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.
Dunque il paesaggio, e per estensione il patrimonio culturale, è definito dalla percezione della comunità che lo “utilizza” e lo “modella”, ed è dotato di caratteri propri che variano in relazione al contorno, all’area geografica di riferimento, e all’azione delle persone che lo “vivono”?
E i caratteri culturali di una comunità si rappresentano come tasselli identitari in quanto da questa comunità percepiti?
Guardiamo, ascoltiamo, parliamo, sentiamo, annusiamo, mangiamo in un determinato modo e dunque siamo e dunque definiamo il nostro intorno?
Ma se è vero che la percezione di chiunque popola il territorio è rilevante ai fini della sua definizione, allora tutte le percezioni devono essere rilevate prima di essere definite inadeguate anche storicamente?

A questo proposito mi ritorna in mente un seminario sul Piano Paesaggistico Regionale del 2010, in cui Giulio Angioni, antropologo e scrittore sardo scomparso nel 2017, sottolineava la difficoltà a far corrispondere una norma, di per sé ferma e certa, a una definizione di paesaggio mutevole e multiplo. Angioni evidenziava il fatto che lo stesso paesaggio valutato rappresentativo da un contadino, avrebbe potuto non esserlo per un pastore, introducendo così la variabile soggettiva delle aspettative del percettore, a cui aggiungeva una variabile oggettiva secondo la quale, per esempio, la stessa frammentazione fondiaria avrebbe potuto essere intesa in senso negativo, se ragionata nell’ottica di una coltura intensiva che consenta economie di scala, o positivo se pensata nell’ottica di una diversificazione delle colture garante di una continuità di approvvigionamenti nel caso di crisi di una mono coltura.
Lo studioso concludeva rappresentando che, al netto delle diverse percezioni, era evidente l’esigenza di una mediazione sociale, scevra da egoismi individuali e guidata dal senso comune, facendo intendere con ciò che la norma, nello specifico il Piano Paesaggistico Regionale, non doveva essere intesa come un dogma ma bensì come espressione dell’indirizzo politico di sviluppo di una comunità.
Ne deduco che la gestione del patrimonio culturale è frutto di mediazione, in quanto atto politico che indirizza la vita pubblica, mentre il patrimonio culturale è dato dalla sommatoria delle percezioni della popolazione di riferimento e la sua conoscenza è uno strumento propedeutico allo sviluppo di un territorio.
Allora riscrivo su ChatGPT la mia conclusione: “il patrimonio culturale definisce le diverse percezioni della popolazione di una certa area geografica nel tempo e serve a tenerne vivo il pensiero critico“.
ChatGPT mi risponde “Hai ragione!”
Non ha colto la differenza tra la sua risposta iniziale e la mia conclusione ma del resto come potrebbe … Io sono una dei circa 11.000 abitanti di Siniscola la cui percezione, da convenzione europea, definisce il patrimonio paesaggistico di riferimento e lei no!
Al netto dell’ironica “barrosia”, ritengo che proprio da questa consapevolezza possa scaturire una visione più lucida del patrimonio culturale e da lì un senso di appartenenza capace di scelte di sviluppo, individuali o collettive, connesse con il territorio.
Miriam Cossu
Architetta