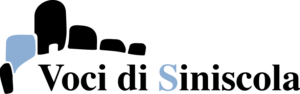Era il 2 Febbraio del 1955, festa della candelora, e mentre le campane suonavano allegre, mio nonno vestito con gli abiti della festa, camicia bianca, giacca e pantaloni a isporta di velluto nero e gambali lucidi, usciva dalla messa cui ogni tanto si recava.
Quel giorno era emozionato per via di quell’appuntamento importante che lo attendeva.
Con il compare si diressero verso i locali della parrocchia dov’era fissato l’appuntamento con i funzionari dell’ente.
Era emozionato, incredulo, speranzoso come ogni buon credente ed impaurito come ogni normale essere umano, con famiglia a carico da sfamare. Era la giornata in cui, per effetto della riforma agraria i funzionari dell’Etfas – Ente per la Trasformazione Fondiaria ed Agraria in Sardegna – avrebbero venduto le terre da coltivare agli assegnatari ed alle loro famiglie, persone dalla grande volontà, o forse incoscienza, pari alla loro fame.
A mio nonno venne dato il podere numero 25 a Capo Comino e a ricordarlo c’è ancora una targa in marmo sulla parete della casa colonica, con l’alloggiamento per il vessillo nazionale ed il nome di San Giovanni, il suo nome appunto.
Quelle terre erano allora distese di pietre, polvere ed erbacce e l’opera per renderle fertili fu davvero notevole in termini di sacrifici, rinunce e grande isolamento.
I miei nonni allora avevano sette figli, tra cui uno appena nato, e iniziarono a lavorare quei campi da subito.
Prendevano la corriera da Siniscola e raggiungevano il podere dove, a seconda dei lavori da completare, restavano lì per giorni, senza alcun alloggio, se non la protezione di un telo steso sotto il carro.
Scrivo questi ricordi grazie ai racconti di mia madre, la primogenita, che mentre mi elenca date ed eventi torna indietro nel tempo con lucida sofferenza per asserire senza tentennamenti che il lavoro svolto su quelle terre li aveva resi schiavi. Infatti non tutti ressero e qualche famiglia rinunciò dopo qualche mese ad una vita fatta di sola fatica in una terra avara ed isolata, lontana da tutto e da tutti.
Per qualche anno lavorarono i campi da pendolari. Entrarono nella casa colonica il 5 gennaio del 1958 e quella notte nessuno dormì, per l’emozione del cambiamento che da una piccolissima dimora nella corte ‘e sos Coroneddos li aveva portati in quell’enorme casa, dove le loro voci rimbombavano nel vuoto delle alte pareti che la luce delle candele non riusciva ad illuminare, e per l’attesa della befana.
Chissà con quale spirito e con quali paure mia nonna donò in quella notte una manciata di mandorle ai suoi figli.

E’ ormai tardi per chiederglielo, ma è lì che tanti anni dopo, bambina, vissi una splendida magia, quando vidi la befana, nitidamente stagliata sullo specchio luminoso della luna piena.
Nelle case non c’era ancora acqua, né luce e l’acqua per i campi veniva portata da una sorta di pozzo, in realtà uno scavo aperto nei pressi della salinedda, dove l’acqua era salmastra e d’estate si prosciugava. Per l’acqua potabile invece, lei e mia zia Francesca andavano alla fontana de su petrarvu, si caricavano la brocca sul capo e ripartivano verso casa.
Una volta accadde che giunte nei pressi di casa, una folata di vento fece volare la brocca dal capo di mia zia, che si frantumò a terra spargendo il prezioso liquido, ormai irrecuperabile e vanificando tutta la fatica.
Negli anni successivi ogni mattina arrivava un trattore con la botte dell’acqua potabile, che stazionava nella borgata e le famiglie potevano approvvigionarsi più agevolmente.
I panni d’inverno venivano lavati nel torrente che scende a sa salinedda mentre d’estate, circa una volta a settimana, mia madre o mia zia, riempito un sacco venivano in paese con la corriera, e poi si dirigevano alla fonte di Frunch’e oche. Lì lavavano i panni sulle pietre, li stendevano ad asciugare e poi rifacevano tutto il percorso a ritroso, fino a casa con la corriera. Erano quelli momenti di fatica ma anche di svago poiché potevano scambiare qualche chiacchiera con le altre ragazze del paese.
Racconta mia madre che una volta mentre era alla fonte, arrivò mia nonna per darle il cambio e mandarla insieme ad altre ragazze dell’Etfas ad una gita organizzata dall’ente. Ma mia madre, testarda ed orgogliosa, non ne volle proprio sapere. Le ho chiesto quale fosse la mèta della gita ed ho capito che probabilmente non si era persa niente: le sue coetanee erano state portate in visita in altre Etfas dell’isola, altre zone isolate dove altre ragazze sacrificavano la giovinezza per un pezzo di pane.
Mentre i primi tedeschi si accampavano sotto i ginepri, i miei zii sotto il sole cocente e gli scatti fotografici dei turisti incuriositi, spietravano i campi: raccontano che in un solo anno tolsero 70 carrelli di pietre e ancora oggi il colpo della zappa non si insinua con facilità nel terreno.
I campi erano coltivati a grano mentre nei pressi delle case coltivavano un piccolo orto, con ortaggi primaverili, come fave, piselli e patate cui bastava l’acqua piovana, mentre d’estate non c’era possibilità di annaffiare costantemente l’orto. Per gli ortaggi estivi si dovette aspettare il 1962, quando in quella primavera arrivò finalmente l’acqua corrente, ed anche il decimo figlio per i miei nonni.
Millina Spina